Il cinema tra scrittura in versi e scrittura in prosa
Drejer, Vampyr, 1932
Nei primi anni di vita del cinema ci sono dei film brevissimi, materiati di irripetibile intensità, con i quali viene preservata l’emozione del primo istante di un movimento reale che viene sottratto all’insidia latente del tempo differito, scarne opere aforistiche che non danno il tempo alla macchina percettiva di calibrarsi e di assuefarsi alla nuova condizione del tempo simulato, segmenti minimi di un poetico, essenziale cinema creativo che respira nell’Ottocento con forme di straordinaria densità, e nel primo Novecento poi l’innesto in film più lunghi di sporadici ma intensissimi, affascinanti momenti di scrittura in versi rivela la necessità profonda che gli artisti più colti avvertono di mantenere in vita quella iniziale e sfuggente freschezza percettiva con la quale si costituisce la vera specificità di questo strumento creativo che è il cinema.
Da questa necessità di vincolare l’ossigeno nascente del precario movimento reale ha preso corpo un raro cinema di ricerca poetica capace, nonostante lo sviluppo ipertrofico e infestante del cinema narrativo scritto in prosa e fondato sulla stabilità dell’ipnotico movimento differito, di continuare a cercare con fatica una possibile scrittura in versi.
La ricerca di uno sguardo puro: Muybridge
E.Muybridge, Animal locomotion,1887
Amazzonomachia, dal Mausoleo di Alicarnasso, 350 c. Londra BM
Quando, dal 1872, l’inglese Eadweard Muybridge sperimenta negli Stati Uniti la sua tecnica fotografica con un sistema di fotocamere allineate che fissano il passaggio di corpi in movimento, egli ha in mente la figurazione antica dei corpi nudi in battaglia, ed è per questo motivo, per questa disarmante consapevolezza di un disegno stagliato lucidamente contro lo spazio astratto, che le sue sequenze conservano tuttora un’irripetibile e straordinaria freschezza: è una creatività di altissimo livello, quella di Muybridge, che emerge con prepotenza anche laddove l’autore pensa se stesso come scienziato sperimentatore del movimento animale.
E la visione perturbante della sua donna obesa e nuda che per un attimo si alza e si riadagia a terra dimostra la capacità di questo geniale fotografo di adottare la purezza di uno sguardo di inedita intensità che in quel momento poteva essere condiviso solamente con il più colto e sensibile dei pittori americani del tempo, Thomas Eakins, che realizza le sue opere più vitali proprio negli anni ’70 (lo studio di Donna seduta del Filadelfia Museum, così vicino alla donna obesa del fotografo, è del 1875), un pittore che si interessa alla fotografia di Muybridge fino al punto di realizzare anche lui delle magnifiche sequenze stroboscopiche di corpi in movimento.
L’irripetibile emozione dell’istante iniziale
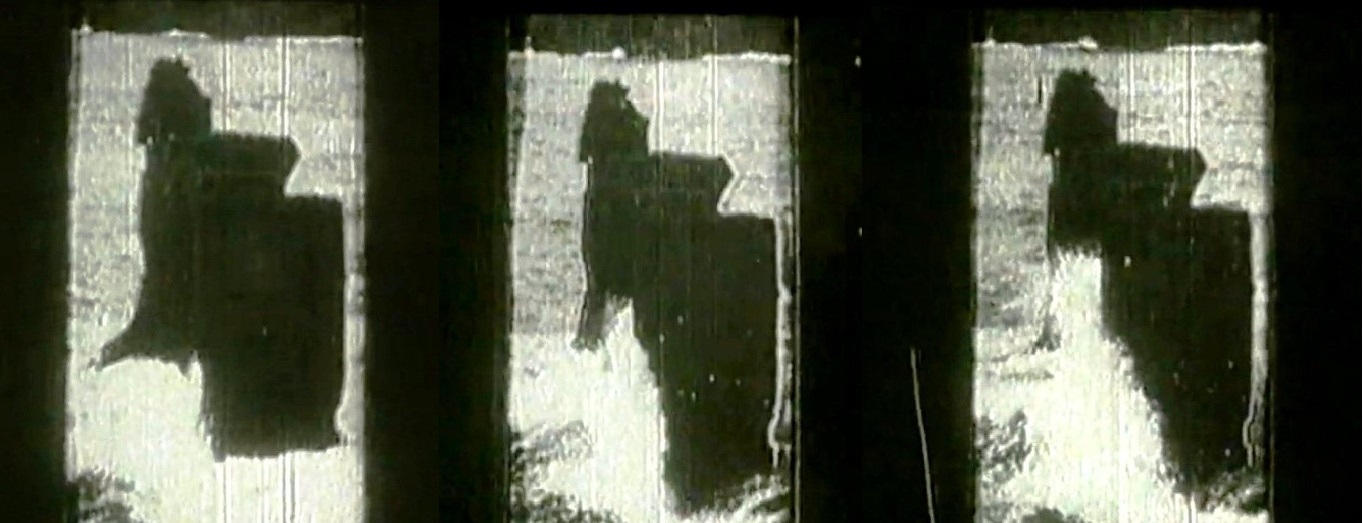
E-J Marey, L’onda, 1892
Negli anni ’80, poi, il geniale fisiologo francese Etienne-Jules Marey sviluppa con grande intelligenza le sperimentazioni di Muybridge portando in dote una sensibilità visiva fuori dal comune, e anche lui è uno scienziato che, pur operando senza avere una esplicita finalità creativa, realizza opere d’arte tra le più affascinanti di quegli anni di fine Ottocento, sul crinale storico che divide il tempo della sperimentazione più autentica e necessaria dall’incombente macroscopica accademia dell’ipnotico manierismo novecentesco.
Negli incunaboli lirici di Marey la purezza della prima intuizione poetica del movimento corrisponde alla ricerca estrema di Niepce e all’ipersensibilità di Talbot: l’Onda, del 1892, dura pochi secondi, ma è il film più autentico che l’intera storia del cinema abbia mai realizzato; i pochissimi fotogrammi, proiettati in sequenza, materializzano per un istante un arcaico blocco di ombra che subisce la collisione con un flusso di luce abbagliante, una visualizzazione di estrema fascinazione che può essere stata nutrita solamente dalla pittura più rarefatta di Corot, e questa delicata luce bianca e pittorica che corrode per un attimo il plastico e funereo monolite nero sintetizza secoli di indagine sullo sguardo e non è il primo film, è un invalicabile e definitivo, emozionato punto di arrivo come lo sono in quel momento la pittura di Cezanne, la poesia di Mallarmé, la musica di Brahms e il pensiero di Bergson.

Marey, Dèplacement des globules de sang dans un vaisseau capillaire, filml microchronophotographique,1891-1892
Il brevissimo film di Marey del 1891-1892 che registra il flusso del sangue ha un’intensità parossistica che toglie il respiro, ed è inevitabile sorridere al pensiero degli sterili e ingenui film astratti del manierismo novecentesco, frutto dell’incredibile e ottusa cecità che ha impedito a lungo agli artisti e agli studiosi di capire il significato della drastica e irreversibile creatività di Marey, meraviglioso principe dell’esilio del cinema.
Sea at Dover

Birt Acres e R.W.Paul:Rough Sea at Dover,1895;J.Turner, Pioggia, vapore,velocità,1844,Londra
E anche il film inglese dell’ipersensibile Birt Acres, Rough Sea at Dover, del 1895, nasce da una intenzionalità esclusivamente scientifica, eppure la sua magnifica, convulsa pittoricità risente profondamente della pittura più avanzata di Turner e di Constable: con la stessa matrice formale de L’Onda, di Marey, Acres forgia una sequenza di pittoricismo allo stato puro che imprigiona la percezione nella morsa di una morbosa fascinazione.
La declinazione impressionista di Louis Lumiere
Quando in quello stesso anno, nel 1895, Louis Lumiere, aiutato dal fratello Auguste, proietta a Parigi i suoi 25 film della durata di un minuto, questi non offre altro che il risultato finale, additivo, di una lunga sperimentazione a più voci che è stata dedicata per decenni alla tecnica della ripresa e della proiezione; basti pensare che in quell’anno veniva pubblicata a Londra quella che Ceram, nel suo Archeologia del cinema (1965), ha definito ‘la prima opera sulla cinematografia’, la History of the Kinetograph, Kinetoscope and Kineto-Phonograph (1895) di W. Dickson, collaboratore di Edison.
Lumiere in definitiva ha semplicemente dato la possibilità al cinema di svilupparsi in forme macroscopiche e ripetitive, con un passaggio fatale dalla qualità necessaria alla quantità manieristica, non diversamente da quanto ha fatto Daguerre spingendo la fotografia di Niepce nel tunnel della più ossessiva ripetizione seriale, un fenomeno che evoca l’analogo passaggio dal leggero aliante del 1900 (qualitativo), di Wilbur e Orville Wright, all’aereo a motore del 1903 (quantitativo e additivo).
Nei film di Lumiere agisce comunque una cultura educata dall’Impressionismo: La sortie du port è debitore di Monet, Lungo il Nilo è trasparente e cartaceo come un acquarello, l’intenso Lavandaie, la sua opera più interessante, è contratto in minute variazioni epidermiche e denso come una tela di Bonnard.
Louis Lumiere, La sortie du port, Lungo il Nilo, Lavandaie,1895.
La grammatica del verosimile
Il cinema sperimentato negli Stati Uniti da Thomas Alva Edison già dal 1891, intanto, ha già costruito la struttura industriale del cinema narrativo novecentesco: collegamento organico con il sonoro, ostentata e consapevole banalità quotidiana dei soggetti, triste e vuoto naturalismo privo di necessità, ricerca epidermica dei più risibili effetti visivi desunti dalla tradizione della lanterna magica. Il manierismo prosastico e aridamente meccanico di Edison corrisponde perfettamente alla fotografia descrittiva di Daguerre ed ha il solo scopo di mettere a dimora nell’immaginazione l’illusione seduttiva di uno spazio e di un tempo astorici, paralleli al tempo reale, in vista di una effimera liberazione catartica che offre un (illusorio) sollievo con l’ipnotica ripetizione all’infinito di moduli facilmente ripetibili.
Edison, films del 1896 e del 1891-94
Edison, fotogramma da un film del 1910
Edison, Frankenstein, 1910
Il mediocre naturalismo di Edison da inizio al cinema descrittivo, e nel 1903 E.S. Porter, con The great train robbery (Attacco al treno) ne consolida gli elementi desunti dalle arti figurative: montaggio, prospettiva, disegno naturalistico. E’ l’avvento irreversibile del verosimile, del tempo differito che sostituisce il tempo reale, mentre Mélies, dal 1902, trascrive e deposita in immagini filmiche il vernacolo del teatro popolare che sarà poi destinato a confluire nell’estetica della Televisione.
Il cinema scritto in versi : Rye
Ma nel 1913 un film straordinario di Stellan Rye, Lo studente di Praga, mostra una guglia affascinante di pura creatività che avrebbe potuto contrastare con dignità l’irruzione impetuosa della retorica e della demagogia del cinema industriale americano. Nel film di Rye sono innestati nel tessuto descrittivo convenzionale dei lunghi momenti di acuto addensamento dell’immagine che hanno un equivalente nella più inquietante pittura implosa di Bonnard: in una sequenza di cinema puro, una donna scende le scale di un cortile e il suo corpo affonda tra le pareti della scala e i gradini, il piano del visibile qui è gradualmente e interamente plasmato di materia, la donna si gira in basso per uscire dalla scala e noi siamo immersi in uno stuporoso magma opaco di emozionante e indimenticabile pastosità materica. Per un attimo il flusso del racconto differito è sospeso, deraglia e implode nella vivida, stupefacente percezione sensoriale di un evento reale che sta accadendo nel momento esatto in cui lo si avverte con il proprio corpo (e siamo negli anni cruciali di Husserl).

Rye, Lo studente di Praga,1913; Bonnard, un dipinto del 1925
Più avanti, nella scena del cimitero, le figure si muovono spaesate tra le quinte perturbanti delle grandi lapidi con una impressionante suggestione di prospettiva contratta che è un ricordo forse del Cimitero ebraico presso Oudekerk,(1653-1655) di J. Van Ruisdael. Per trovare dei film che siano altrettanto materiati di una tale intenzionalità creativa è necessario aspettare il Golem di Wegener (1920) e il Carretto fantasma di Sjostrom (1921), i film di Drejer e i preziosi momenti isolati di Lang, pagine splendide che fanno rivivere la magnifica intensità degli stupefacenti frammenti compressi all’interno del film di Rye.
Il doppio binario della demagogia e della retorica
Ma intanto, un anno dopo, nel 1914, è già in atto con forza irresistibile il doppio binario della demagogia e del populismo, con la serie di idiozie di Chaplin e con la greve fascinazione retorica dannunziana di Cabiria. E nel 1915 la Nascita di una nazione di David Wark Griffith formalizza una volta per tutte l’impiego del montaggio e della prospettiva come radicale disinnesco di quella perturbante contrazione percettiva che dagli incunaboli di Marey si era sedimentata nel cuore de Lo studente di Praga, mentre Intolerance, di Griffith (1916), sostituisce alla delicata scrittura in versi di Rye la prosa potente dello spettacolo esteriore, trasmutando con invasiva prepotenza i valori della qualità in quantità, e a questo doppio binario del cinema narrativo, alla squallida riduzione lessicale delle commedia e alla triste cauterizzazione della tragedia svuotata di senso, si associa la ripresa euforica dello spettacolo ipnotico già inseguito dai brevi film ottocenteschi fino a Melies e culminante nelle opere del laboratorio Edison del 1910: Abel Gance, con il suo Folie du Docteur Tube del 1915, esaspera le illusive deformazioni plastiche per mostrare come il cinema possa seguire le sperimentazioni dell’avanguardia più esteriore impegnata sterilmente ad impressionare e stupire.
Lirismo poetico di Sjostrom
Evidentemente è in corso un braccio di ferro tra la prepotente scrittura in prosa del cinema industriale e la generosa scrittura in versi del cinema poetico: nel 1913 lo svedese Victor Sjostrom, educato da Ibsen e da Strindberg, inizia a pensare il suo cinema dell’interiorità con Ingeborg Holm; nel 1916 crea Terje Vigen, da Ibsen; nel 1918 realizza I proscritti, da un poema di J. Sigurdjonsson, dove vige un dolore scabroso e senza esito (Louis Delluc vede nel film ‘acuto lirismo’ e ‘sincerità’, individuando ‘Un terzo interprete, il paesaggio’, e definìsce I proscritti ‘il più bel film del mondo’). Sjostrom ama evidentemente la pittura di Friedrich, lo dicono il mare in Terie Vigen e gli abissi di vuoto de I proscritti: la sua opera, che vede un’adesione appassionata alla tradizione figurativa della pittura, dimostra che la specificità del cinema può essere arricchita dal pensiero dell’inquietudine (Kierkegaard), dalla letteratura e dal teatro (Ibsen, Strindberg).
Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia,1817;Sjostrom, Terie Vigen,1916
Sjostrom, I proscritti, 1918
Quando nel 1920 Sjostrom crea Il carretto fantasma su testo di Lagerlof, ottiene, scrive Moussinac, ‘un lirismo finora mai raggiunto sullo schermo’ e ‘i suoi film sono ( ) acqueforti molto spinte’.
Questa volta Sjostrom guarda alle opere più acute di Munch: la forma trasparante del carretto funebre scorre febbrile sulla materia del fondo come se fosse dipinta sul vetro opaco, i corpi si sdoppiano in sovrimpressione e si muovono dolenti all’interno di uno spazio instabile eternamente materiato di ombra; quando il carretto, guidato dalla morte, sta per inabissarsi in mare, siamo di fronte davvero ad una incisione di Munch aggravata e potenziata da un doloroso e quasi impercettibile smottamento sismico che fa vibrare in silenzio una sconvolgente materia melmosa.

Sjostrom, Il carretto fantasma, 1921

E. Munch, Nuit, incisione
Nel tunnel dell’entropia
Le fragili suggestioni del cinema espressionista
Nello stesso anno, nel 1920, quella grafia ossessiva e implosa visibile nel Carretto fantasma è declinata in senso spettacolare e scenografico ne Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, un generoso tentativo di tradurre la pittura dell’Espressionismo tedesco in cinema mutuando soprattutto i cristalli acuti e le xilografie arcaizzanti di Kirchner alla ricerca di una straniante e fragile materia cartacea, mentre Il Golem di Paul Wegener costruisce invece uno spazio interamente plasmato di volumi sfatti dall’ombra; sono le opere più interessanti e vive di un fronte che la cultura Europea scava per arginare la diffusione infestante del cinema commerciale.
Negli anni di Freud (Il perturbante, 1919), a questi film della colta reazione europea si aggiungono nel 1922 La stregoneria attraverso i secoli, di Benjamin Christensen, con la potente visualizzazione di una luce discontinua e in movimento che si trasmuta in luce ferma e indagatrice, Femmine folli (1922) di Erich von Stroheim, che alimenta la percezione sfocata e morbosa della crudeltà, e Nosferatu il vampiro (1922) di Friedrich Wilhelm Murnau, stremato da trasparenze delicatissime che dicono la vulnerabilità organica.
Ma il contenutismo e la vocazione al racconto suggestivo si stanno ormai imponendo come norma inderogabile, trainando la specificità pura del cinema nel territorio ereditato dal romanzo e dal teatro. Quando il sensibile Murnau, vicino all’ambiente creativo del Blaue Reiter, realizza L’ultimo uomo, nel 1924, introduce nella scrittura filmica uno sprofondare inquietante nel campo visivo che sembra voler ritrovare la densità di Rye, ma il contenuto patetico e la presunzione retorica del racconto sconfiggono la forma, e il suo mediocre e a tratti goffo Aurora del 1927, realizzato in America, ratifica l’asservimento delle fertili soluzioni formali al risibile contenuto narrativo del testo.
Il caso di Murnau conferma il cinema come arte figurativa dall’esistenza fragilissima, una tecnica che ottiene la sua precaria, preziosa e rara autenticità, in paradossale contrasto con la mole immensa delle opere realizzate nel corso della sua storia, solamente quando la cultura dell’autore e la sua consapevolezza sanno mettere in salvo il tempo reale individuale attivando l’esaltazione perturbante della percezione, perchè il cinema, come la fotografia, è destinato fin dalle origini ad essere autentico solo quando lotta coraggiosamente contro una micidiale energia trainante, contro l’irrefrenabile forza di gravità della contraffazione aristotelica del verosimile che lo trascina nella landa sconfinata, ipnotica e sterile del tempo differito.
La sperimentazione tentata dalla stilizzazione
E adesso siamo nel pieno dominio del manierismo novecentesco: i film di Man Ray (Le retour à la raison,1923) e di René Clair (Entr’acte, 1924) conservano in parte la freschezza del Cinesarge sperimentale del primo Novecento, ma anche queste sono opere già paurosamente segnate dall’invecchiamento precoce dell’arte contemporanea e dall’infestante manierismo ipnotico che condiziona ormai gran parte di quanto viene realizzato in quegli anni.
La sperimentazione interdisciplinare sconfitta dalla retorica
E d’altra parte perfino le opere realizzate nel 1925 e nel 1926 da Sergej Ejzenstejn mostrano un doloroso paradosso: l’impegno interdisciplinare di questo autore, dotato di una grande, impulsiva creatività e di una tersa intelligenza, sono segregate nei limiti strutturali di un contesto fin troppo fertile che coinvolge in un vasto processo di osmosi architettura, design, poesia e musica, ma all’insegna di una tetra demagogia capace di condizionare con il suo ottuso contenutismo, anche lo sperimentalismo più liberatorio; nei film di Ejzenstejn, purtroppo, anche i momenti di più felice ideazione sono troppo debitori delle arti figurative, come dimostra l’acuta visualizzazione della forma cancellata nella sequenza dell’attacco con gli idranti in Sciopero (1926), desunta fin troppo evidentemente del geniale e severo Raggismo di Larionov di dieci anni prima.
L’equivoco del vuoto sperimentalismo epidermico
Ed è significativo che negli stessi anni l’opera più densa di Abel Gance, Napoléon (1925-1927), non sia altro che un superficiale insieme di pretestuose trovate tecniche prive di vera necessità e sempre asservite ad un racconto di arrogante e goffo monumentalismo.
La faticosa ricerca della scrittura in versi
Non stupisce quindi che in un momento storico così vitale per la musica, l’architettura e la letteratura, il cinema corra il rischio di sprecare l’emozionante e inedita disponibilità degli strumenti creativi con opere che, pur essendo materiate di generosa e passionale intenzionalità poetica, mostrano una troppo debole struttura interna: il seducente La coquille et le clergyman di Germaine Dulac su progetto di Antonin Artaud (1926), I misteri di un’anima, del sensibile e colto Georg Wilhelm Pabst (1926), La chute de la maison Usher (1927) dell’ipersensibile Jean Epstein raffinato lettore di Poe.
Rari segmenti lirici imprigionati dalla retorica degli spazi architettonici: Lang
Ci sono però, tra queste opere, degli inserti di grandissimo fascino che pur nella loro brevità, innestati come sono in film di grandi proporzioni, attestano l’altissima qualità che potenzialmente il cinema può raggiungere come strumento creativo.
In Metropolis (1926), Fritz Lang esaspera la visualizzazione dello spazio architettonico già sperimentata con il wagneriano I Nibelunghi (1923-1925), debitore delle scarne scenografie di Appia e di Craig, ma in due straordinarie sequenze collocate nel cuore dolente del film Lang concretizza con uno spasma una perturbante alternativa a questo spazio razionale: nel frenetico inseguimento sotterraneo la luce della lampada opprime la figura sconvolta di donna che si sottrae a quella morsa ustionante svicolandosi febbrilmente lungo l’incubo di una parete cavernosa che la calamita con forza, con una irripetibile intensità plastica che trasmuta la recitazione teatrale in pura performance, un inserto incredibile che vive nel buio del film come la notturna Kammermusik, ispiratrice di Webern, giace nel centro della Settima sinfonia (1905) di Mahler.

In una magnifica sequenza successiva, la donna (il disegno scomposto della sua forma) cerca di fuggire attraverso un lucernaio e noi vediamo per un attimo, con angoscia, la sua figura, il lacerto sfatto del disegno del suo corpo, emergere sgranata verso di noi per sprofondare poi nuovamente in una materia sorda di insostenibile, morbosa caoticità.
Purezza della scrittura in versi: Drejer
La prima (e unica?) opera realizzata interamente come pura opera plastica arriva nel 1928 con La passione di Giovanna D’Arco di Carl Theodor Dreyer, lirico continuatore di Sjostrom. Ma questo potente fregio ininterrotto (che è stato considerato, come era forse fin troppo prevedibile, tra i dieci film più belli di tutti i tempi) esula in parte proprio dalla specificità del cinema perchè mette in scena con troppa intenzionalità un’impressionante visualizzazione della tradizione dell’arte figurativa: apre con il protagonismo di vasti spazi architettonici cavi, si consolida a lungo (sul volto in primo piano dell’attrice) come densa massa plastica, e infine, in coincidenza con il dramma finale, si scompone in puro spazio pittorico. Il film di Drejer mostra il tentativo estremo del cinema di sopravvivere al contenutismo teatrale e romanzesco rievocando senza remore tutta l’energia dell’arte, e l’equivoco del tempo differito che assorbe e sospende il tempo reale qui viene evitato con una sintesi mai tentata prima che vede tre dimensioni creative compenetrarsi come se la percezione le stesse intercettando in un solo unico momento del tempo reale dove lo spazio vuoto contiene dei volumi plastici che si dissolvono in pittura. Non c’è il racconto di un processo a Giovanna, c’è l’evento della forma che sotto i nostri occhi attraversa le fasi della sua metamorfosi.
Carl Theodor Dreyer, La passione di Giovanna D’Arco,1928
Dopo il film di Drejer tutto appare troppo letterario e superficiale, anche le opere piene di delicato stupore di Pabst (Lulu, il vaso di pandora, 1928; Il diario di una donna perduta, 1929), frutto di un genuino interesse per la Psicoanalisi, mentre i film surrealisti di Luis Bunuel e di Jean Cocteau (Sang d’un poète,1930) segnano il punto di arrivo più stanco del triste manierismo novecentesco destinato ormai a spengersi poi nella ripetizione accademica delle innumerevoli performance teatrali che da quei film attingono ancora oggi la loro materia.
Sintesi irripetibile di lirismo e verità:Vampyr
Ma il grande testo del cinema interamente redatto in versi appare solamente nel 1932, pochi anni dopo la presunta adozione tecnica del sonoro (che il cinema ha sempre avuto, da Edison e in poi) con il quale si accelera la metamorfosi di questo strumento creativo in messa in scena teatrale e romanzesca costringendo il cinema di ricerca poetica a scavare un suo sempre più difficoltoso percorso ormai quasi invisibile.
Drejer crea il suo perturbante Vampyr, lo sappiamo, in uno stato di grave, dolorosa agitazione interiore, e il risultato è paragonabile al perturbante I Quaderni di Malte Lauridis Brigge (1910) di Rilke, ugualmente materiato di lirismo visionario e ugualmente radicato nella pura specificità della sua tipologia creativa.
Con Vampyr, Drejer spinge alle estreme conseguenze quanto ha elaborato con La passione di Giovanna d’Arco in termini di osmosi tra le arti figurative: l’autore sembra voler accentuare il racconto con il ricorso a lunghe e fuorvianti didascalie cartacee, ma tutto ciò che nel film viene narrato è in realtà una zavorra priva di importanza, nel film non accade niente, c’è solamente lo sguardo fisso di chi si aggira incredulo in un mondo di suggestioni puramente visive e sensoriali, e quello sguardo attònito si specchia nel nostro, è lo sguardo allibito che viene adottato da chi sta vedendo il film. Qui non c’è il tempo differito che strappa la materia viva del tempo reale, perchè è il nostro sguardo che sta operando in tempo reale, stiamo guardando qualcosa che esiste davvero, lì davanti a noi, come capita leggendo Ulisse di Joyce, laddove ci accorgiamo di pensare e ricordare, in tempo reale, solamente ciò che già sappiamo e che siamo in grado di descrivere (sia il film di Drejer che il romanzo di Joyce infatti turbano e respingono solamente coloro che non possono e non vogliono esserne i protagonisti reali).
Lo sguardo che opera in Vampyr è uno sguardo divagante che registra frammenti incerti di ombre, un guardare inquieto che incorre di continuo in sviste e che scandaglia inutilmente lo spazio circostante dove non c’è niente da vedere.
Vampyr, per la prima e per ultima volta, è solamente cinema allo stato puro, perchè chi lo ha creato ne ha sofferto la profonda e acuta necessità. Siamo sul confine tra ciò che il cinema dell’istante iniziale ha cercato di tenere in vita, da Marey a Sjostrom, e ciò che il tempo del verosimile catartico aristotelico sta ormai colonizzando senza tregua con una irresistibile campagna di conquista e di dominio che ha un precedente di tali proporzioni con l’opera lirica ottocentesca.
Nel cuore di questo magnifico film c’è una sequenza che ne mette a nudo la struttura radicale: il protagonista (il nostro sguardo) irrompe in una stanza e scandaglia ansiosamente con gli occhi senza vedere altro che la realtà di quel posto vuoto.

Drejer, Vampyr, 1932: sequenza dello sguardo da destra in alto verso sinistra in basso
Dopo Vampyr la vicenda del cinema come forma d’arte necessaria è conclusa. Il cinema non poteva offrire più di così. E con Quarto potere (1941) di Orson Welles si impone l’ossessione di quella innovazione forzata che ha condizionato e calamitato, fino ad oggi, gran parte della creatività contemporanea creando il triste mito della più retorica avanguardia accademica: gli espedienti tecnici, come avveniva nel Napoleon, di Gance, sono esibiti mediocremente per servire al racconto retorico e demagogico. E in questa faglia perfino le reazioni più generose al prepotente dominio del mediocre racconto descrittivo sono condizionate e sminuite dal contenutismo, come accade con Meshes of the afternoon (1943) della delicata Maja Deren, e con il sincero e struggente Un chant d’amour (1950) di Jean Genet.
Il malinconico invecchiamento precoce del cinema di Stan Brakhage
All’inizio degli anni ’60, un autore sinceramente coinvolto in una creatività esente dalle leggi del mercato come Stan Brakhage (Anticipation of the Night, 1958) avrebbe potuto forzare l’argine del contenutismo retorico se non avesse subito i limiti angusti della cultura americana più presuntuosa che ha voluto vedere in Pound un modello di retorico ritorno ad una presunta purezza delle origini. Il suo Sirius Remembered del 1959 riproduce troppo enfaticamente e acriticamente la gestualità di Pollock, mentre il monumentale Dog, Star, Man del 1964 è appesantito da ingenue e insensate ripetizioni di forme vuote (l’oscillazione della macchina da ripresa, le patetiche visioni astronomiche), banali soluzioni lessicali che oggi fanno (tristemente) sorridere.
Stan Brakhage, Sirius Remembered, 1959; Pollock al lavoro
Ammirevole accordo di forma e contenuto. Alain Resnais
Nei primi anni ’60 Alain Resnais trova una soluzione ideale di forma e contenuto con due opere di straordianria intensità che indagano la stessa specificità del Cinema: L’anno scorso a Mairenbad (1961) e Muriel, il tempo di un ritorno (1963). Cfr. Resnais. Il cinema della percezione sensoriale (1980-2021)
Un poetico principe dell’esilio: Ed Emshwiller
Eppure, nonostante la vasta sedimentazione del cinema scritto in prosa e la sconfitta del cinema come forma d’arte, è possibile comunque trovare nel tempo delle preziose opere isolate ancora materiate di autenticità, come è il caso dell’impressionante Thanatopsis del 1962, una pagina di straordinaria freschezza immaginativa di Ed Emshwiller che uno studioso miope, con involontaria comicità, definì ‘senza ombra di fascino’.
In Thanatopsis viene visualizzata, inconsapevolmente, la lotta tra la materia degli inumatori e quella degli inceneritori. In contrasto con la massa plastica di una testa immobile, si agita epilettico l’ectoplasma frenetico di una forma irrefrenabile che ruota attorno a quel volume statico per sprofondare poi in un tunnel luminoso di frammenti liquidi; un testo (unico, forse, nel lavoro di questo autore) interamente redatto in versi emozionati che rievocano la memoria remota degli stupefacenti studi sul movimento dell’aria e del fumo di Marey.
Ed Emshwiller, Thanatopsis (1962)
Sintesi poetica tra forma e contenuto
E The brig (1964), di Jonas Mekas, oppone l’autenticità e la necessità alle scolastiche sperimentazioni di Andy Warhol di quegli stessi anni (Sleep, 1963; Empire, 1964). Ancora una volta, un film puro nasce non dal tentativo sterile e presuntuoso di evitare il racconto descrittivo, ma dall’intensità della rarissima e difficile sintesi poetica tra forma e contenuto; Mekas si limita a filmare lo spettacolo del Living Theatre del 1963, e questa pura registrazione di un evento teatrale di ossessiva matericità, di divorante assorbimento della percezione visiva, si concretizza in un film che anche in questo rarissimo caso riesce a frenare e inibire lo slittamento del tempo reale nel tempo differito grazie alla cruda identificazione di chi guarda con la fisicità estrema dell’evento.

J. Mekas, The brig, 1964
In quel tempo, comunque, la generosa ricerca di soluzioni poetiche porta ad opere di suggestiva intensità emotiva, come quella realizzata nel 1964 da Samuel Becket (Film), ma l’equivoco del contenutismo più greve inficia lo sperimentalismo permeato di imbarazzante visionarietà religiosa di P. Kubelka (Arnulf Rainer, 1969) e di Tony Conrad (The flicker, 1966), mentre le opere più ambiziose di Michael Snow, Wavelengh (1966) e La regione centrale (1970), risultano oggi ipertrofiche e manieristiche derivazioni (quantitative) dei preziosi minuti (qualitativi) di Vampyr, esattamente come le arroganti costruzioni musicali di K. Stockhausen lo sono dei delicati, minuti pezzi aforistici di Anton Webern.
L’involontario splendore del cinema occasionale: The Blair Witch Project
Eppure il greve cinema ipertrofico, dominatore incontrastato del Novecento, è stato contraddetto a sorpresa proprio a fine secolo da un evento sorprendente che può essere compreso solamente se lo si colloca nel contesto inedito di un fenomeno di vastissime dimensioni che associa la moltiplicazione all’infinito delle camere per la videosorveglianza, con la loro asettica e purificata visione priva di scopo, alla diffusione parossistica delle webcam in rete dove il mondo è indagato incessantemente e catalogato nei suoi momenti inerti in una illimitata distesa amorfa che paradossalmente rinnova proprio il piacere della visione ritrovando una freschezza e un disinteresse che l’insopportabile finzione costruita così stupidamente negli studi dell’industria del cinema ha vanificato.
Nel 1999 due giovani, Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, realizzano The Blair Witch Project, un testo magnifico e involontariamente poetico che deroga bruscamente da tutte le norme del cinema accademico per mutuare le sue forme esclusivamente dal cinema spontaneo amatoriale e dalla negligente, scarna comunicazione delle webcam.
Il commento più interessante e rivelatore su questa opera lo ha scritto un giornalista ottusamente ostile ad un film che viene creduto dai più ingenui un falso diffuso in rete:’L’uso ossessivo della macchina a mano disturba, se non impedisce, l’identificazione tra spettatore e schermo ( ) il dialogo troppo gridato dei tre protagonisti ( ) introduce un ulteriore elemento di disturbo e nega ogni verosimiglianza psicologica ( ) per non parlare di chi continua a preoccuparsi più delle riprese che di quello che gli sta succedendo’.
Bene, quel giornalista, nella sua idiozia, ha perfettamente ragione: il film disturba, con le sue intollerabili sgrammaticature, l’uso della cinepresa è ossessivo e domina completamente il tempo reale impedendo l’instaurarsi del tempo differito, il dialogo nega ‘ogni verosomiglianza psicologica’ perchè riproduce, come le webcam, l’impossibile naturalezza e l’imbarazzo di chi è filmato e registrato in ogni suo momento, e l’attenzione è sempre rivolta alla ripresa, al fatto cioè che tutto quello che stiamo vedendo è solamente una ripresa e non una impossibile (e indesiderabile) realtà.
The Blair Witch Project è un lavoro collettivo, immerso in una inconsapevole esteticità diffusa, che non pretende di avere nessuna qualità estetica, nasce dalla mania della ripresa ossessiva e coatta di tutto quello che accade nutrendosi esplicitamente dell’estetica non professionale: la sua forma affascinante deriva da quella stessa fretta disinteressata che ha portato alla sequenza delle seducenti e occasionali fotografie di cronaca bruciate dall’urgenza e materiate di un involontario lirismo arcaico, di un meraviglioso armonico di memoria che affiora proprio nel momento della massima distrazione della coscienza.
Il film, che apre come si aprono gli occhi, con una opaca messa a fuoco, e chiude come si chiudono gli occhi, con una slabbrata visione offuscata, è pura percezione dall’inizio alla fine, in esso non c’è altra artificiosità se non quella, ostentata e mostrata per quello che è, della più banale registrazione di un campo limitato e sostanzialmente insignificante del visibile, perchè qui, come in Vampyr, in realtà non accade assolutamente niente. La materia visibile, esasperata dalla doppia ripresa, in bianco e nero e a colori, è sottratta alla fissità opprimente della messa a fuoco scolastica, i movimenti della camera sono goffi e del tutto naturali; è abolita ogni forma di recitazione artificiosa, e laddove sembra esserci, come nella confessione notturna nella tenda, si tratta della pseudo recitazione alla quale sono abituati gli adolescenti che riprendono se stessi con la webcam. The Blair Witch Project è un’opera materiata di esteticità in ogni suo dettaglio, con una felice e involontaria coincidenza di spontaneità e di autenticità, perchè il pathos irrelato che pervade con la sua anossia tutto il film, nutrito di profonda e inquietante, sconvolgente autosuggestione, è quello che faceva soffrire crudelmente (nella realtà) l’attrice della Giovanna d’Arco del 1928 e lo stesso Drejer durante la creazione di Vampyr nel 1932.


The Blair Witch Project (1999): inizio del film, riprese in movimento nel buio con due camere diverse, sezione finale, blocco delle due cineprese abbandonate a terra e chiusura
1998-2014
